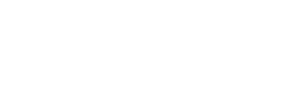Nona di Scalve 1661 – 1725
Come certi fiori di rara bellezza sbocciano talvolta nelle fessure meno prevedibili di una roccia, così nella più alta – e per certi versi nascosta – frazione della Valle di Scalve trovò i suoi natali lo scultore Giovanni Giuseppe Piccini. Protagonista di un’arte straordinaria in cui il piccolo è il grande e l’umano è la forma pura del divino.
Giovanni Giuseppe Piccini nasce a Nona di Scalve nel mese di Settembre del 1661. Ancora giovanissimo, viene avviato a bottega dal padre presso un falegname intagliatore della valle. Nel 1671 si trova a Vilminore Pietro Ramus, membro di una famosa bottega di intagliatori trentini ma operanti in Valle Camonica. Lavora al completamento del pulpito della Pieve. A lui viene chiesto di prendere a bottega il giovane Piccini. Durante questo periodo di apprendistato, Giò Giuseppe incontra Andrea Fantoni , anche lui a bottega, destinato a diventare il massimo esponente di una famiglia di scultori bergamaschi attivi dal quindicesimo al diciannovesimo secolo. Si frequenteranno anche negli anni successivi, come attestano le stime che Fantoni chiede al Piccini per alcuni lavori. E non mancheranno nemmeno momenti di contrasto, come avvenne per una commissione a Lovere sottrattagli dal Fantoni.
Il Piccini non aveva una grande bottega organizzata come si conveniva in quel periodo e come lo erano proprio le botteghe dei Fantoni, dei Ramus o dei Boscai in Val Sabbia. Disponeva di uno o due aiutanti, per periodi più o meno prolungati. Ne deriva che la sua produzione sia piuttosto contenuta dal punto di vista quantitativo, mentre si distingue per la grande qualità realizzativa e iconografica. Ai paliotti e agli altari si succedevano medaglie e quadretti in legno di bosso finemente scolpiti. Che siano soprattutto le opere di piccole dimensioni quelle in cui risalta maggiormente il tocco delicatissimo e insieme intenso del Piccini è oggi considerazione unanime fra gli esperti.
Amava inserire nelle sue opere citazioni di vita quotidiana, quasi a tradurre l’orizzonte sacro della composizione in quello umano delle situazioni ordinarie. Lo vediamo ad esempio nel S. Rocco di Pezzolo, dove il cagnolino con la zampa gioca col bastone del Santo. Oppure nel bassorilievo della deposizione per la pace di Nona, dove uno degli addetti si aiuta trattenendo con la bocca un lembo del sudario. O, ancora, nella deposizione dalla croce dell’inginocchiatoio di Telgate, dove uno dei personaggi utilizza il proprio corpo come appoggio per il corpo del Cristo, mentre questi viene calato dalla croce.
I primi lavori eseguiti da Gio Giovanni si trovano a Lizzola, Nona, Gorzone e Mazzunno. Si tratta di altari e paliotti policromi dove l’artista, nell’esecuzione dell’intaglio figurativo, applica principalmente le competenze acquisite alla scuola dei Ramus. Nei primi anni Novanta lo ritroviamo a intagliare il paliotto della chiesa di Cedegolo, che andrà a completare l’apparato altaristico iniziato proprio dal suo maestro Ramus.
Agli inizi del Settecento, lo scultore – ormai pienamente affermato – è intento alla produzione di medaglie come quelle attualmente esposte al Castello Sforzesco di Milano; o dei quadretti per i signori Capitanio di Bergamo, ora a Brescia; o al servizio del Conte Borromeo, per il quale realizza l’alto rilievo raffigurante il Naufragio dei discepoli, oggi conservato all’Isola Bella, sul Lago Maggiore. Sappiamo che il Conte offrì a Piccini la possibilità di stabilirsi da lui, ma da buono scalvino preferì salvaguardare la propria autonomia e il radicamento nella terra d’origine anziché cedere alla tentazione del prestigio.
La sua produzione statuaria e altaristica continua sia in Valle Camonica che in Valle di Scalve con altre opere per la chiesa di Nona, come il disegno per il portale d’ingresso, il mobile per la sacrestia e il confessionale. Intorno al 1710 realizza l’altare della Pietà nella chiesa di Dezzo; poco dopo, l’altare dei Santi di Azzone. Poi ancora l’altare per la chiesa di Pezzolo. Intorno al 1714 realizza l’altare maggiore per la chiesa di S. Andrea e nel 1719 scolpisce le statue per l’ancona di Schilpario. Seguono le sculture per l’ancona della Madonna del Rosario a Vilminore.
Dopo aver seminato così tanta bellezza dentro e fuori i confini della sua valle, Giovanni Giuseppe Piccini muore a Nona nel 1725. Un documento intitolato “Nota di alcune opere d’intaglio”, a firma dello stesso scultore, ha reso possibile la corretta attribuzione di molte delle opere da lui realizzate.
Per approfondire
Chiara Spaino, Giovanni Giuseppe Piccini scultore, Bolis, Bergamo 2011.


Copyright CAI 2024 Sottosezione Valle di Scalve